Il Velluto nel Rinascimento
- theOne Costumes

- 31 mar 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Il velluto affermò con decisione il suo primato fra tutti gli altri tipi di tessuti nel secolo XV, nel teatro delle apparenze e della codificazione delle gerarchie sociali, in cui le vesti hanno sempre avuto un ruolo altamente significativo, la sua presenza testimonia la nobiltà e l'importanza dei personaggi.
Negli affreschi, negli arazzi, nei quadri, nelle miniature che ci restituiscono i fasti delle corti e la solennità delle cerimonie religiose, gli stessi velluti di seta, baluginanti di trame d'oro, rivestono, circondano identificano i santi, i potenti ed i re.

Se l'unione di questi due materiali preziosi era già nota e riservata da molti secoli alle massime gerarchie sociali, la forma in cui venne diffusa nel Quattrocento, quella del velluto broccato d'oro, era relativamente nuova e straordinaria per effetto e per tecnica di lavorazione.
I sontuosi sciamiti sassanidi e bizantini, i lampassi trecenteschi dai fantastici disegni, vanto delle manifatture lucchesi, non offrivano le molteplici possibilità estetiche del velluto. Non materializzavano inoltre così concretamente e vistosamente l’idea che chi se ne rivestiva era cosciente di vivere in tempi nuovi: nel Quattrocento, specialmente in Italia, centro di produzione del velluto, il potere non significava più nascita e stirpe, ma anche e soprattutto denaro e ricchezza.
Del filato serico, nella lavorazione cinese ed in quella occidentale del periodo medioevale, si tendeva piuttosto ad esaltare la straordinaria finezza, che permetteva la tessitura di stoffe la cui levità e lucentezza non trovava paragone. Le vesti in seta, portate dagli imperatori, dai papi e dai re suggerivano un'immagine di levità ultraterrena.
La seta li avvolgeva in morbidi e lucenti panneggi, che coprivano e svelavano insieme, come si conveniva alla manifestazione della divinità.
Rispetto alle sete bizantine, persiane, lucchesi, il velluto si presentava invece come un tessuto pesante, solido, consistente; le membrana che ne erano rivestite non venivano trasfigurate, ma ridisegnate plasticamente.
Al suo primo apparire il velluto si rivelava un tessuto di indubbia connotazione virile, perfetto ornamento di principi e condottieri. Il suo possesso testimoniava potere e ricchezza, ma creava a sua volta ricchezza e potere a chi ne conosceva i segreti di produzione. Divenuto, come oggetto di leggi suntuarie che ne definivano e limitavano l'impiego, simbolo di rigide gerarchie sociali, il velluto manifestava nell'uso reale sovvertimenti di ordini e di valori.
Accessibile ad un numero sempre più vasto di persone, venne nel corso del Quattrocento a caricarsi di sempre nuovi contrassegni che ne sottolineavano il prezzo, la rarità, la distinzione, nel vano tentativo di riaffermarsi quale prodotto elitario ed esclusivo.
I più antichi velluti, quelli datati intorno al XIV secolo, sono poco numerosi, ma non per questo meno interessanti. Oltre ad alcuni frammenti più semplici a righe e a quadretti, alcuni importanti pezzi confermano le indicazioni fornite dalle fonti scritte contemporanee, secondo cui venne intensificandosi, con il progredire del secolo la presenza di velluti operati, policromi, broccati d'oro nei guardaroba reali.
II loro valore era decisamente superiore a quello di tutti gli altri tessuti, specialmente se tinti nel pregiato rosso di chermes. In pochi anni essi conquistarono il primato nella produzione tessile di lusso destinata ai potenti, decretando il tramonto dello sciamito e del drappo che per secoli era stato incontrastato dominatore nel panorama della tessitura serica.

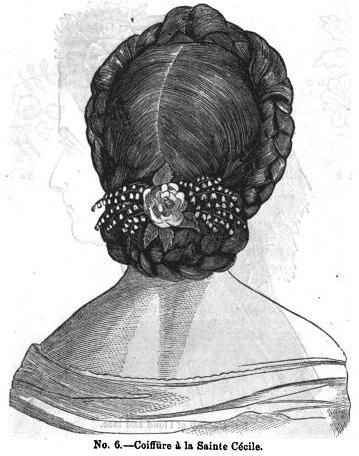


Commenti